Il nuovo romanzo di Begoña Feijoo Fariña «Per una fetta di mela secca» (2020, Gabriele Capelli Editore), racconta attraverso una protagonista immaginaria l’atroce destino vissuto da migliaia di vittime dei collocamenti coercitivi praticati in Svizzera fino a 40 anni fa.
La Pgi Coira aveva previsto per la primavera 2020 una serata con Begoña Feijoo Fariña. Non avendo potuto tenere un incontro pubblico, abbiamo intervistato l’autrice per telefono.
Begoña Feijoo Fariña, cosa l’ha spinta ad occuparsi di un tema così doloroso?
Il primo motore è stato il documentario di Mariano Snider (ndr. Cresciuti nell’ombra, RSI, 2015). Fino ad allora io non sapevo niente degli internamenti coercitivi. Era un giorno d’estate del 2016, sono capitata su questo documentario e l’ho guardato e riguardato, non so quante volte. Non potevo crederci! Il mio primo pensiero è stato: quando i miei genitori si sono separati, una decina di anni dopo la fine di queste misure, io, i miei fratelli e la mia mamma eravamo in assistenza. Che fine avrei fatto io, se fossero state ancora in vigore questo tipo di misure? Avrebbero permesso a mia mamma di tenermi? Ho sentito che dovevo scrivere su questo argomento, così tutto ciò che stavo facendo è passato in secondo piano e ho iniziato a documentarmi. Allora c’erano dei testi in tedesco, ma non mi risulta ne esistessero in italiano. Di seguito è stata tradotta la testimonianza di Sergio Devecchi (ndr. Infanzia rubata, Casagrande, 2019) e sono stati pubblicati Silenzi (di Luca Brunoni, Gabriele Capelli Editore, 2019) e Il mio nome era 125 (ndr. di Matteo Beltrami, Edizioni Ulivo, 2019).
Pensa che i riconoscimenti da lei ottenuti con questo progetto rispecchino una volontà collettiva di elaborare una pagina di storia svizzera vergognosa?
Per quanto riguarda il sostegno ricevuto dal Cantone dei Grigioni (ndr. Concorso Grandi Progetti, 2018), penso che il tema abbia avuto un peso, anche perché la storia, pur essendo inventata, è possibile e legata ai Grigioni. Per Pro Helvetia (borsa letteraria, 2018) conta invece piuttosto la qualità dell’elaborato proposto che non il tema in sé.
Più persone mi dicono che sarebbe il caso di portare il romanzo anche nelle scuole e si stanno muovendo in questo senso. Penso che per i ragazzi leggere il testo avrebbe senso soprattutto come monito: bisogna stare attenti ai giochi di potere nella società, nelle situazioni istituzionalizzate dove ancora c’è un guardiano e un guardato.
Ha già ricevuto dei riscontri da vittime dei collocamenti coercitivi che hanno letto il romanzo?
Non ancora, ma ho avuto un riscontro da una figlia di una vittima, collocata in un istituto di suore da piccolissima, perché la madre era rimasta vedova con diversi figli. Questa signora mi ha detto che leggendo il libro fino in fondo ha capito alcune cose di sua mamma. Grazie a quello che io ho scritto ha capito dei comportamenti di sua madre e per me questo è molto bello.
La protagonista del romanzo è una bambina di Cavaione. Cosa l’ha portata a scegliere questo piccolo villaggio della Valposchiavo?
L’idea originale era di far partire tutto da Corippo. Questo minuscolo villaggio della Val Verzasca, il comune più piccolo della Svizzera, mi affascinava. Inoltre ho conosciuto delle persone provenienti da lì, molto più anziane di me, che per come le ho conosciute, avrebbero potuto essere state vittime di queste misure. Poi iniziando a parlare del tema in valle (ndr. Valposchiavo), una delle prime cose che mi è stato detto è stato: “Da noi non succedeva!”. Ma non ci si ricorda, non succedeva veramente, oppure c’era dell’omertà? Ho dunque voluto cercare notizie negli archivi, ma non vi ho avuto accesso, perché non sono persona direttamente interessata ai fatti. Una persona mi ha però detto che conosce una signora anziana del comune di Brusio a cui sono stati portati via due bambini da piccoli. Qualcun altro mi ha detto di essere sicuro che ci fossero stati dei casi…quindi ho capito che succedeva, ma non se ne parlava, oppure le persone della generazione a cui mi sono rivolta non se ne ricordano o non avevano realizzato, perché all’epoca erano bambini. Quindi ho deciso di ambientarlo in Valposchiavo, poi ho scelto Cavaione per le analogie con Corippo.
È stata aiutata da qualcuno per l’ambientazione storica?
Ipoteticamente io ho fatto nascere Lidia (la protagonista) nel ’56 e poi sono andata d’istinto.
Non mi sono fatta aiutare un granché ma ho fatto alcune domande per esempio sulla scuola e sulla costruzione della strada di Cavaione ad Anna e Secondo Balsarini, che sono nati nel villaggio in quegli anni. Prima delle correzioni finali loro hanno letto il libro per vedere se c’erano delle cose che non funzionavano con la Cavaione che hanno vissuto da bambini. Nel testo c’è anche una canzone che loro cantavano da ragazzi.
Immaginare quella che poteva essere allora la vita di un piccolo villaggio non mi è risultato particolarmente difficile perché, pur essendo vero che io sono di un’altra generazione, sono nata in un paese (ndr. la Spagna) uscito dalla dittatura nel ’75 e che quindi è rimasto a lungo arretrato. Io l’ho fatta quella vita lì, da bambina! Vivevo con i nonni in un piccolo paese, non di montagna, ma molto rurale, dove tutti sapevano tutto di tutti. A casa di mia nonna, dove ho vissuto per anni, c’erano tre stanze più la cucina e non avevamo il gabinetto, finché i miei hanno mandato i soldi dalla Svizzera. Il bagno si faceva in un grosso secchio, che si usava anche per raccogliere le patate. Si dormiva in tre in un letto. Era veramente un’altra vita, arrivare a Lugano per me è stato uno shock.
Non sarebbe stato più facile da scrivere e da vendere un romanzo rosa?
Più facile da scrivere? Per me probabilmente no. Penso di non esserne capace! Da vendere, lo capiremo fra alcuni mesi. Personalmente sono molto fiera di questo lavoro, del prodotto finale, di essere riuscita a trovare quell’ingenuità che cercavo. Se vende più o meno di «un rosa», lo scopriremo.
Il contesto storico
Dagli anni ’40 fino al 1981, in Svizzera vigeva la prassi di affidare, d’ufficio e contro la volontà dei diretti interessati, bambini e giovani a istituti o contadini. Le migliaia di collocamenti interessarono bambini provenienti da famiglie povere, figli illegittimi o appartenenti a situazioni familiari precarie, ragazzi considerati difficili, scomodi o ribelli. Molte delle vittime di tali decisioni di collocamento coercitivo sono state mandate a servizio, sfruttate in aziende agricole, internate in istituti psichiatrici o penitenziari, maltrattate, sottoposte ad adozioni forzate o hanno subito (spesso a loro insaputa) sterilizzazioni. Nel 2013 la Confederazione ha chiesto pubblicamente scusa per la sofferenza inflitta.
Begoña Feijoo Fariña
Nata in Galizia nel 1977, vive in Svizzera da quando aveva 12 anni. Laureata in biologia, si è occupata per anni dello studio degli insetti. Nel 2015 lascia l’ambito scientifico per dedicarsi al teatro e alla scrittura e si trasferisce in Valposchiavo. Nel 2016 pubblica il romanzo Abigail Dupont (Demian edizioni, Teramo) e nel 2017 Maraya (AUGH!, Viterbo). Per una fetta di mela secca (Gabriele Capelli Editore, Mendrisio, 2020) è il suo terzo romanzo, che nel 2018 le è valso il Concorso Grandi Progetti del Cantone dei Grigioni e una borsa letteraria di Pro Helvetia. Per lo stesso progetto è stata ospite della Residenza Franz Edelmaier per la letteratura e i diritti dell’uomo a Merano.
«L’hanno fatto perché qualcuno ha potuto farlo e nessuno si è opposto.»
Begoña Feijoo Fariña
Intervista a cura di Arianna Nussio, operatrice culturale Pgi Coira

















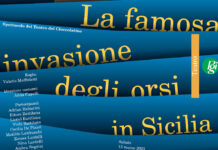

Bellissimo libro e brava Begõna. Un libro così dovrebbe esserci in ogni casa.
In silenzio tanti bambini hanno vissuto maltrattamenti e ingiustizie infinite. Penso sia assolutamente doveroso parlarne. Ogni bambino ha il diritto di essere AMATO!