La storia è un elemento fondamentale di riferimento per capire e prevedere il futuro. I temi, le tendenze, i comportamenti protendono a riproporsi in forme diverse nei secoli e il decantato progresso, lo abbiamo raggiunto sì con la tecnologia, ma come esseri umani fondamentalmente siamo rimasti gli stessi: quelli della pietra e della fionda*.
L’evoluzione non ha contribuito molto a cambiare gli atteggiamenti delle persone, delle popolazioni e dei governanti, purtroppo le caratteristiche umane ci condannano a rimanere gli stessi di sempre. Anzi possiamo osservare, con una certa preoccupazione, che la tecnologia e la globalizzazione hanno ampliato gli strumenti di sfruttamento economico e di controllo, li ha resi più potenti e performanti. Non sempre ce ne rendiamo conto, ma siamo manipolati e strumentalizzati dai grandi gruppi di potere che reggono le sorti economiche del mondo. I valori etici, fra le poche cose che danno valore e dignità alla persona, sono stati ridotti e banalizzati dalla legge di mercato.
Essere una minoranza linguistica è un costo
Non siamo più cittadini con diritti e doveri, ma siamo stati degradati al ruolo di consumatori seriali di servizi pubblici e prodotti. Questa mentalità ha invaso da decenni anche i sistemi democratici di governo; oggi, essere una minoranza linguistica è un costo, come lo è vivere nelle vallate alpine, istruirsi, curarsi ed essere allacciati alle vie di trasporto o collegati alle reti telematiche. Meno si è omologati e centralizzati all’influenza del mercato, più i costi delle infrastrutture e dei sevizi pubblici aumentano. Le esigenze e le necessità del popolo sono sempre più definite da formule numeriche, che non sempre tengono in considerazione il contesto in cui sono applicate. Questo criterio vale per la sanità, per la scuola, per le infrastrutture pubbliche e viarie, per le lingue a livello federale. In alcuni ambiti, lo strumento della perequazione finanziaria federale e cantonale tenta parzialmente di porvi rimedio. I tempi in cui si affermava che la politica aveva il primato sull’economia sono tramontati, oggi sono le statistiche e gli algoritmi che giustificano se un intervento è necessario oppure no.
Recentemente, il cantone dei Grigioni ha dichiarato di avere un capitale proprio di 2.4 miliardi e il risultato operativo per l’anno 2017 ammonta a 128,8 milioni. Del capitale proprio i fondi vincolati ammontano a 1,6 miliardi e il capitale liberamente disponibile raggiunge i 782,9 milioni. Se si confrontano i consuntivi dei comuni con quelli del cantone emerge un notevole disequilibrio fra i fondi a disposizione dei comuni in rapporto al cantone, capitale a favore del cantone alimentato in buona parte con i soldi dei cittadini e delle aziende. Lo Stato non è una banca e non dovrebbe accumulare delle riserve eccessive, ma avere un bilancio in equilibrio fra entrate e uscite, promuovere e mantenere le infrastrutture pubbliche efficienti e creare le basi per uno sviluppo adeguato e sostenibile su tutto il territorio cantonale. Lo sviluppo lo si appoggia a livello pubblico creandone le basi, questo dovrebbe avvenire a livello federale, cantonale, regionale e comunale. Non sempre si ricava questa impressione, lo sviluppo non può essere delegato semplicemente ai privati con uno sgravio d’imposta, senza che il Cantone e i Comuni ne abbiano definito le condizioni quadro. Il divario crescente fra città e periferia, tra mondo rurale ed economico oppure quello fra le varie minoranze linguistiche, rischia di rendere la Svizzera, che si definisce una nazione fondata sulla volontà comune di stare assieme, più un mito che una realtà. Infatti, queste linee di conflitto generano continuamente delle tensioni, che lentamente minano alla base le fondamenta dello Stato. Il mondo cambia, cambiano gli stili di vita, i consumi, i linguaggi, mutano i mestieri. La funzione della politica consiste quindi nella capacità di misurarsi con le novità, guidandone i processi di mutamento permanente nel modo più giusto e sostenibile. Affrontare il problema significa cambiare il paradigma iniziando dalle piccole cose.
Se a livello locale le comunità come le nostre non sono più in grado di esprimere e definire le loro possibilità di uno sviluppo sostenibilie e duraturo investendo le risorse finanziarie proprie sul territorio, hanno sciupato le poche opportunità a disposizione. La strategia degli investimenti pubblici sul territorio dovrebbe distanziarsi dalla logica e dai parametri dei processi economici globali, su cui noi non abbiamo nessun influsso, e pensare a un’incremento regionale a lungo termine. Sebbene in valle ci siano alcuni progetti in questa direzione, a noi sembra mancare la volontà generale e l’inziativa comune nel definire un concetto di sviluppo territoriale e di investire le risorse comunali e cantonali a favore di una economia regionale mirata.
*Salvatore Quasimodo: Uomo del mio tempo
Renato Isepponi


















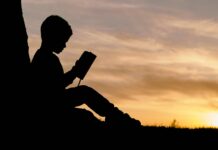
Sono della stessa opinione.
Bravo Renato
Renato hai colpito nel segno. Vedrei volentieri un ritorno ai tempi del:
“Uno per tutti, tutti per uno”.
Grazie e cordiali saluti
Mario
Un’analisi fuori dal comune. Riflessioni e spunti interessanti. Originali. Necessari.
Grazie Renato. E complimenti.