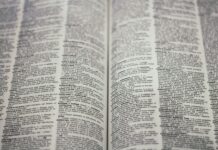Venerdì sera, 8 novembre, nell’Aula Riformata a Poschiavo si è tenuto un incontro dal titolo Imbarazzismi con lo scrittore e medico Kossi Komla-Ebri. Originario del Togo e residente in Italia dal 1974, Kossi è un esponente della letteratura migrante in lingua italiana. Attraverso la sua opera e la sua attività di mediatore interculturale, affronta le situazioni quotidiane in cui il razzismo si intreccia con l’imbarazzo, creando quelli che lui definisce imbarazzismi. Con l’ironia come arma principale, Kossi smonta pregiudizi e discriminazioni, trasformandoli in opportunità di riflessione sulla società contemporanea.
Alla base di questi imbarazzismi c’è quello che nelle scienze sociali viene definito etnocentrismo, ossia la tendenza a giudicare la cultura dei gruppi umani diversi dal gruppo a cui si appartiene secondo i valori propri di quest’ultimo, tenuto come ideale punto di riferimento. Questo atteggiamento, spesso inconsapevole, influenza profondamente la percezione del mondo, portando a escludere o vedere come estranee le abitudini altrui. Ne deriva un immaginario condizionato dai pregiudizi, che si riflette nei rapporti sociali e nella costruzione dell’identità. L’identità, come sottolinea Kossi, si costruisce infatti attraverso la relazione con l’altro. Oggi, spesso, l’altro fa paura; rappresenta qualcosa di estraneo, di alieno, e pertanto suscita un impulso di rifiuto e di distanziamento da ciò che risulta essere diverso da noi. Ma, sottolinea Kossi, «l’altro non è il nemico; è chi ci permette di essere quello che siamo»: l’altro è dunque un elemento fondamentale per identificarci.
In questo contesto, Kossi propone di rivedere il concetto di integrazione. «L’integrazione – spiega – è l’interazione delle nostre diverse integrità». Non bisogna cercare di vedere ciò che abbiamo di diverso, gli elementi che ci differenziano, l’uno dall’altro, ma dobbiamo partire dalle cose che abbiamo in comune. Solo in questa maniera quello che l’altro ha di diverso diventa prezioso, un arricchimento a quello che già abbiamo in comune: «l’integrazione mi porta qualcosa che io non ho; non è qualcuno che viene a distruggere ciò che già sono».
La parola, portatrice di significato, e pertanto anche di possibili pregiudizi, svolge un ruolo fondamentale in queste dinamiche e nella costruzione e nella definizione di un immaginario, ossia: essa, anche per mezzo di termini specifici riguardanti la sfera identitaria, plasma l’immaginario e l’identità di una comunità.
Che le parole sono importanti lo dimostra bene Kossi, prendendo come esempio il termine extracomunitario. Per definizione, questo è un aggettivo impiegato per intendere chi proviene da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Ma raramente si pensa ad uno svizzero all’estero, o ad un americano espatriato, come extracomunitario; la parola assume dunque una sfumatura razzista, e contribuisce a plasmare un immaginario negativo, fatto di pregiudizi verso chi, essenzialmente, di fronte ad una parola del genere viene emarginato, subendo un attacco, velato ma pur concreto.
Non solo il linguaggio verbale, ma anche quello non verbale può essere offensivo. Gesti, espressioni e atteggiamenti corporei spesso veicolano messaggi discriminatori, più forti di qualsiasi parola. È il caso degli episodi che Kossi definisce imbarazzismi. Durante l’incontro, lo scrittore ha condiviso una sua esperienza significativa: un giorno, mentre aspettava il treno, due carabinieri lo notarono da lontano, attraversarono i binari e si avvicinarono per chiedergli i documenti. Dopo aver verificato che era un medico italiano, si scusarono e fecero per andarsene. Kossi, però, li fermò con una domanda: «Perché, tra tutte le persone in stazione, avete scelto proprio me?». Qui, la risposta dei carabinieri assume le forme di quella frase fatta – «guardi che noi non siamo razzisti!» – che inconsapevolmente rivela il motivo della perquisizione: un morboso e sistematico sentimento razzista o, in termini più specifici, un caso di profilazione razziale, una pratica spesso impiegata dalle forze dell’ordine che utilizza la razza o l’etnia come criteri per decidere se fermare qualcuno. Con ironia, infine, Kossi fece notare ai carabinieri che è vietato attraversare i binari a piedi, ribaltando così la dinamica dell’interazione. Questo episodio riflette bene il suo approccio agli imbarazzismi, i quali vengono affrontati con ironia, la quale funge da «corteccia» per difendersi dal razzismo sottile e al contempo mettere in discussione l’assurdità dei pregiudizi. Con leggerezza e intelligenza, come spiega Kossi, l’ironia smonta gli stereotipi, evidenziandone l’infondatezza e invitando a una riflessione critica sulle dinamiche alla base di atteggiamenti come quello dei carabinieri in stazione.
L’incontro con Kossi ha offerto spunti profondi su come affrontare i pregiudizi e costruire un dialogo autentico attorno al fenomeno del razzismo e della diversità. Solo riconoscendo l’altro come una risorsa e smantellando le basi dell’etnocentrismo, ad esempio con il meccanismo dell’ironia, si può trasformare l’imbarazzo – o, meglio, l’imbarazzismo – in opportunità di crescita e l’integrazione in un arricchimento reciproco.