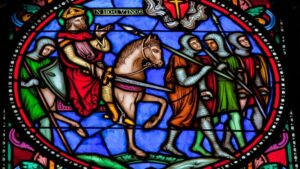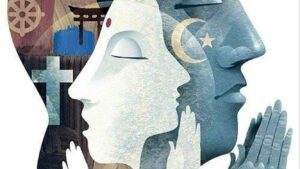Il rapporto tra le religioni e la pace non è mai stato semplice. Lo stiamo constatando anche in questo nostro tempo. Si potrebbe dire, e si dice – a giusta ragione -, che il divino vuole la pace, la insegna, la stimola, la predica, condanna la guerra e la violenza. Dalla Bibbia si cita il sermone sul monte, dal Corano i versetti che ricordano che chi uccide un uomo è come se uccidesse l’intera umanità. Non pochi guardano verso l’Oriente e indicano la via del Budda.
Nei fatti, purtroppo, non è stato sempre così, e non è così neppure oggi. Gli esempi sono tanti. Le religioni, al di là delle belle e pacifiche parole, hanno benedetto armi e soldati e hanno spinto a combattere, ciascuna in nome del proprio dio. Mentre parlavano di amore, hanno stimolato l’odio. Oggi qualcuno prende le distanze dalle dottrine sulla guerra giusta, ma bisogna anche dire che molti altri continuano a crederci.
Religione e fondamentalismo
Il problema del rapporto tra religioni e pace si ripresenta, in questo tempo in cui l’umanità dimostra una volta di più di non saper convivere senza odiarsi e farsi del male. È un problema particolarmente difficile per chi, malgrado tutto, continua a credere nella parola di Gesù che “i mansueti”, non i violenti, “erediteranno la terra”. Ma viene subito da chiedersi: chi renderà gli esseri umani “mansueti”? Lo faranno le chiese? Saranno capaci di farlo le religioni? Quanti fondamentalisti si abbeverano alle sorgenti delle religioni? Dove sono i figli e le figlie mansueti delle chiese e delle religioni? È venuta l’ora, per le religioni, di fare i conti con il fatto che esse stesse possono anche essere, e spesso sono, serbatoi di fondamentalismi.
Perché? Come si spiega che le chiese e le religioni, a parole portatrici di pace, si possono rivelare, nei fatti, portatrici di violenza?
Il veleno del nazionalismo
Di certo uno dei motivi consiste nel collegamento che si è venuto a creare fra una religione e una etnia, un popolo, una nazione. La religione è usata e si lascia usare come una bandiera da alzare sugli spalti e da sventolare in faccia agli altri, ai nemici. Poi si continua a dire che dio è universale, ma a quel punto è diventato un dio nazionale e parziale, un dio che segue le sorti di un popolo, di un gruppo etnico. Nella prima Guerra Mondiale era il «Gott mit uns» dei soldati dell’imperatore tedesco, i quali facevano fuoco contro le truppe inglesi raccolte al grido «God save the King», mentre sulle Alpi austriaci e italiani si bombardavano con artiglierie benedette da preti di entrambi gli schieramenti. In India sono oggi i fondamentalisti indù a discriminare e aggredire musulmani e cristiani brandendo lo slogan «Hindu Rashtra Banayenge» («Faremo dell’Indiauna nazione indù»), nel Myanmar sono i nazionalisti buddisti a opprimere e scacciare i Rohingya musulmani, mentre l’espressione «Allah aqbar» (letteralmente «Allah è il più grande») è diventata un inquietante grido di battaglia degli islamisti.
La sfida del pluralismo
Un altro collegamento che ha scatenato e scatena violenza, è quello tra religione e verità. E la convinzione che la verità è una soltanto e che la mia religione la possiede. Certo, la verità è un bene prezioso, ma siamo sicuri di avere riflettuto abbastanza sul costo della difesa di quella che di volta in volta è stata proclamata verità? E siamo sicuri di avere esplorato fino in fondo la possibilità di coniugare difesa della verità e rispetto per chi la pensa diversamente da noi? Sarà mai possibile staccare la spina che collega la religione da una parte alla etnia, e dall’altra al concetto di verità assoluta? Forse. Ma non è e non sarà facile.
A questo proposito mi pare opportuno ricordare, proprio in questi giorni di spietato confronto tra i fanatici di Hamas e la reazione dei falchi israeliani, l’esperienza di «Wahat al-Salam – Neve Shalom», un villaggio cooperativo abitato da arabi palestinesi ed ebrei israeliani posto a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme. È la sola comunità presente oggi in Israele in cui ebrei e palestinesi, di cittadinanza israeliana – in tutto un centinaio di famiglie -, vivono insieme per scelta. Il Villaggio fu fondato all’inizio degli anni ’70 dal domenicano Bruno Hussar, figura-chiave del dialogo ebraico-cristiano. A «Neve Shalom Wahat al Salam» sorgono ad esempio una scuola primaria bilingue e binazionale (la prima in Israele), una Scuola per la pace e un Centro spirituale pluralista. La direzione del Villaggio ha rilasciato, negli scorsi giorni un comunicato in cui afferma che «non possiamo vivere in tranquillità e sicurezza senza riconoscere i pieni diritti di ogni singolo essere umano, palestinese, israeliano, ebreo, arabo, che vive tra il fiume e il mare».
In conclusione
Oggi occorre riportare il divino nel suo ambito e nel suo ruolo, non solo nelle parole ma anche nei fatti. Un divino che non si ponga in concorrenza con altri e che non si serva della politica per garantirsi privilegi e primi posti. Non più legato a una bandiera, ma amante, fino in fondo, indistintamente, di tutta l’umanità.