Continua il nostro viaggio tra gli insegnanti della Valposchiavo che lavorano oltre Bernina. Questa volta tocca a Luigi Menghini, docente presso l’Alta Scuola pedagogica.
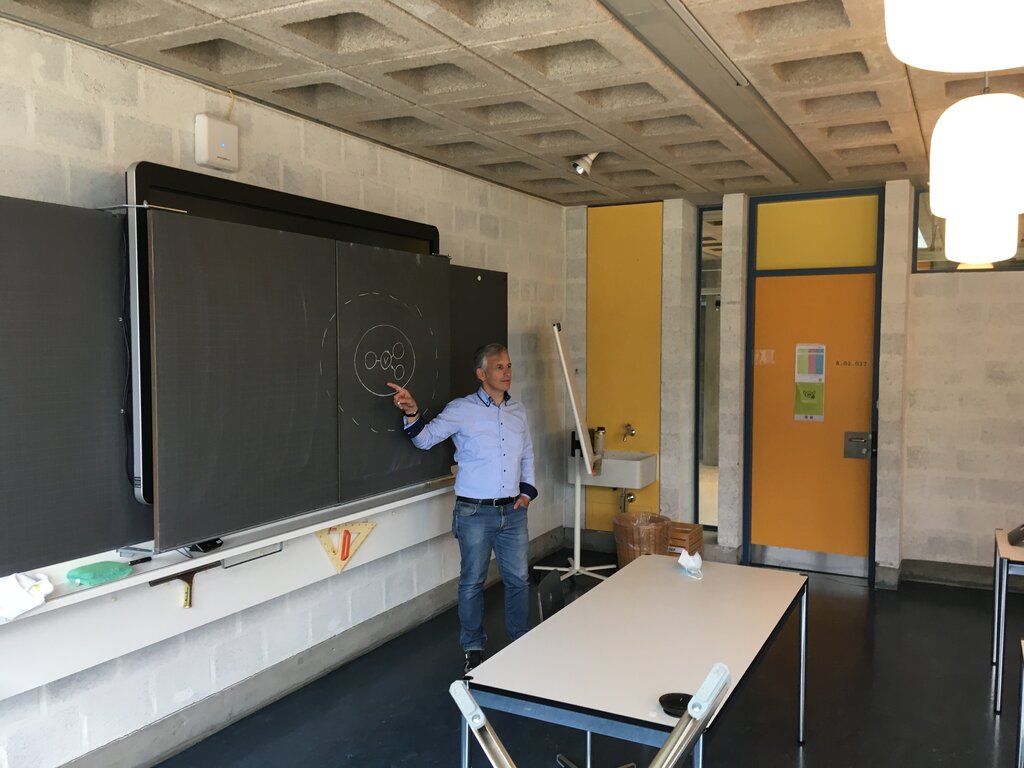
Hai sempre voluto fare l’insegnante?
Allora, sempre è una parola grossa, ma da molto tempo sì. Diciamo che ho iniziato a voler diventare maestro quando ero ancora alunno. Credo che fossimo ancora in quinta o sesta elementare quando venne in visita l’orientatore professionale, che era pure un mio prozio. Ci fece compilare un test, parlammo un po’ e alla fine mi disse: “Potresti fare il maestro”. E da lì in avanti l’idea si fece sempre più strada, capii che mi sarebbe anche piaciuto.
Qualcuno ti ha ispirato, hai avuto un modello a scuola o in famiglia?
Direi che fare l’insegnante è una tradizione familiare. In ogni generazione c’è stato uno di famiglia, che ha insegnato. A cominciare dal mio bisnonno paterno, dal quale ho ereditato anche il nome, poi un mio prozio, un mio zio e infine io.
E quindi ti sei iscritto alla scuola magistrale, poi cos’è successo?
Più o meno, verso l’ultimo anno mi son detto che non volevo iniziare subito a lavorare, anche se avrei potuto insegnare tranquillamente alle elementari, il posto probabilmente ci sarebbe stato. Nel mio immaginario però, volevo diventare insegnante di secondaria e così avrei dovuto iscrivermi all’università.
Una volta finita la Magistrale ho svolto il servizio militare. Per questioni di affinità linguistica, ho fatto la scuola reclute in francese, immergendomi totalmente in questa lingua. Mi sono quindi iscritto all’Università di Losanna, nella facoltà di lettere. Come materie scelsi Italiano, linguistica e francese, non come letteratura ma per insegnarlo come lingua straniera, cambiando orientamento rispetto alla formazione per insegnante di secondaria.
Dopo due anni, mentre ero ancora in pieno studio, mi chiamarono per una supplenza a Poschiavo; c’era stato un prepensionamento ed un posto era vacante. E così sono tornato a Poschiavo, dove ho avuto tutti i miei ex insegnanti come colleghi; l’effetto, entrando nell’aula insegnanti, è ancora oggi presente! Ci sono stato per tutto l’anno, un’esperienza straordinaria. A 22 anni avevo allievi di 16 anni e poco meno, ho avuto addirittura mio fratello e alcuni cugini! Poi ho ripreso gli studi, alternandoli però con supplenze più o meno lunghe; ho avuto cosí la possibilità di mantenermi e ampliare la mia conoscenza di diverse sedi scolastiche del Grigionitaliano. Finiti gli studi, nel 2002 sono tornato a Poschiavo, per altri tre anni.
E come mai non ti sei fermato?
Prima di tutto non avevo la qualifica adeguata al ciclo d’insegnamento: avevo una licenza in lettere e non un diploma per insegnare in secondaria. In quegli anni ci sono stati dei cambiamenti strutturali nella scuola: prima vi era un responsabile di sede, poi invece è cambiato il sistema ed è stata creata la funzione di direttore di sede. In realtà non avevo molte chances, però mi sono annunciato comunque per quel posto e non sono stato scelto. Da parte mia mi sarei volentieri messo in gioco. Dopo aver finito un ciclo intero e portato una classe dalla prima alla terza ho sentito il bisogno di seguire nuove prospettive.
Nel frattempo, c’è stato anche un altro cambiamento importante, quello nella formazione degli insegnanti. Dalla Magistrale si era passati all’Alta Scuola e io ho seguito questi cambiamenti con grande interesse, anche quando ero a Poschiavo. Già dall’inizio scrissi al rettore che, se si fosse liberato un posto come insegnante di Italiano, mi sarebbe interessato. Sul momento i posti, però, erano tutti coperti.
Finito questo ciclo di cui parlavo prima, ho trovato, quasi contemporaneamente ben due posti possibili al 70%, per italiano e francese all’Alta Scuola e per francese a Lucerna. Mi annunciai per entrambi e svolsi i due colloqui nello stesso giorno! Fui accettato in entrambi e optai per quello di Coira. Era il 2005 e sono ancora qui.
Che cosa è diverso nell’insegnamento dalla secondaria all’Alta Scuola?
Ci sono ovviamente parecchie diversità. Ho conservato di sicuro lo stesso entusiasmo che avevo quando insegnavo in secondaria. Allora avevo di fronte dei ragazzi che erano ancora quasi una “materia in formazione”. Oggi invece, all’Alta scuola, ho davanti a me, come studenti, persone adulte con cui confrontarmi.
Come è stato lasciare l’ambiente a te familiare della Valposchiavo?
Non ho mai avuto ripensamenti, né rimpianti. Dopo alcuni anni sono arrivati anche la famiglia e i figli. Ma è stata un’ottima esperienza a Poschiavo; come dicevo prima, avevo intravisto una possibilità di andare oltre. Socialmente quando ero in Valle ero molto assorbito, impegnato in diverse società, le serate erano quasi tutte piene… e mi piaceva anche!
Vedi nei tuoi alunni la voglia di diventare insegnanti?
Sì, perché lo scelgono davvero. Prima, la Magistrale era parallela alla formazione liceale, una possibilità diversa di frequentare una scuola superiore. Quindi molti, la sceglievano e poi alla fine decidevano se diventare insegnanti o studiare altro. Adesso è diverso: tutti quelli che scelgono l’Alta Scuola, lo fanno perché vogliono davvero diventare insegnanti. Certo, lungo il percorso c’è anche chi abbandona, magari sentendosi a disagio nel confronto con allievi. La professione di insegnante elementare è diventata per la stragrande maggioranza femminile. Nella mia classe eravamo quattro maschi, ora gli uomini si sono rarefatti, il 10% suppergiù.
Avete anche allievi grigionitaliani?
Purtroppo pochi, rispetto al fabbisogno di ricambio. Prima la Magistrale era un’istituzione cantonale, adesso possono iscriversi tutti. E arrivano anche studenti extra-cantonali, i Ticinesi soprattutto, perché proponiamo un diploma bilingue. Solo che non riusciamo a trattenerli per occupare i posti che si liberano nel Grigionitaliano e inserirli nel sistema educativo cantonale. Ce ne sarebbero abbastanza, ma poi quasi tutti cercano occupazione in Ticino, oppure nella Svizzera interna.
Perché ci sono pochi iscritti grigionitaliani?
Non lo so, penso che in primo luogo il riconoscimento sociale della professione di maestro sia cambiato. Essere insegnante portava con sé un’aura importante. Era un aspetto che davamo per scontato o che si dava per scontato in generale. Oggi invece può essere logorante entrare in conflitto con genitori, farsi riconoscere nel ruolo di formatori. E poi c’è una burocratizzazione del lavoro notevolmente aumentata. Via via, il lavoro è stato reso più impiegatizio. Si è più controllati e la libertà di azione si è ristretta. Poi naturalmente c’è la questione economica: a parità di impegno formativo esistono carriere che sono decisamente più redditizie.
Che cosa si dovrebbe fare con gli studenti che vengono da fuori?
Sarebbe bene riuscire ad avere studenti anche valtellinesi che facciano la formazione da noi: abbiamo avuto recentemente alcune studenti provenienti dall’Italia: una ragazza di Borgonovo di Piuro, ad esempio, formatasi in Italia, ha recuperato le carenze in tedesco e poi si è integrata nel sistema, facendo propri gli strumenti didattici nostri, ora è una bravissima insegnante. Si è trattato di un’esperienza estremamente arricchente.
Forse si dovrebbe fare anche “propaganda oltrefrontiera” allora?
Una volta superato l’ostacolo della lingua tedesca (che potrebbe essere aggirato andando a pescare chi già lo ha studiato nelle scuole superiori italiane), potrebbe indubbiamente essere una buona idea. Non è mai stato fatto, però potrebbe essere un’opzione. Perché frequentando la formazione qui, un/a studente valtellinese sarebbe portato/a ad inserirsi in modo organico nel nostro sistema scolastico, che rispetto a quello italiano è anche economicamente più attrattivo. Invertiremmo la tendenza: non più “fuga ma afflusso di cervelli”.
















