Fin da piccoli, siamo spinti a imparare le risposte alle domande. Chi conosce le risposte migliori va avanti. A scuola, il sistema di valutazione è costruito sulla capacità di fornire le risposte giuste. Ma così perdiamo di vista l’importanza di sviluppare domande valide e strategiche.
L’importanza delle domande
Il filosofo cinese Confucio, vissuto nel 6. secolo avanti Cristo, ha affermato che “l’uomo che fa una domanda, può sembrare stupido per un momento. Ma quello che non la fa sarà stupido per tutta la vita”. E lo scrittore francese Pierre-Marc Gaston de Lévis ha sostenuto, nella seconda metà del ‘700, che una persona dev’essere valutata” dalle domande che pone e non dalle risposte che dà”.
Il rabbino Adin Steinsaltz ha raccontato, in un’intervista, che il padre di un amico, quando tornava a casa, non gli chiedeva se avesse ottenuto dei buoni voti, ma se avesse posto, durante la giornata, qualche buona domanda. L’aneddoto suggerisce che la qualità più importante, in una persona, è quella di porre domande, di non accontentarsi di ciò che sa, di ricercare risposte.
I perché dei bambini
Tutti sappiamo che bambini o bambine, crescendo, passano attraverso quella che si definisce “l’età dei perché”: tra i due e i cinque anni, i bambini pongono in continuazione delle domande.
Attraverso le loro domande, i bambini costruiscono, e poco per volta precisano, la loro immagine del mondo. Non fanno domande solo per chiacchierare e stabilire un legame con gli adulti, bensì per capire. Ai bambini piace scoprire il perché delle cose: “Perché piove?”, “Perché il cielo è coperto di nuvole?”, “Perché splende il sole?”. I bambini fanno domande per comprendere il mondo che li circonda, il senso della vita, il perché di certi comportamenti, il bene, il male.
Poi però le cose cambiano. Dopo i cinque anni la quantità di domande decresce rapidamente, fino ad esaurirsi. A quel punto, i genitori tirano un sospiro di sollievo: in casa tornano la calma e una situazione di normalità.
La fine delle domande
Ma è davvero un bene il fatto che perdiamo la curiosità infantile? Che smettiamo di fare domande? Che seguiamo le risposte degli altri, invece di formulare una risposta personale? E perché la propensione a domandare comincia a decrescere con l’accesso alla formazione scolastica, e si spegne progressivamente nel corso degli anni di scuola? Siamo certi che il motivo sia da ricercare nel fatto che le domande da porre si sono esaurite? Non sarà invece perché a scuola la priorità è data alla conoscenza e alle risposte, e non alle domande? O perché ai bambini e ai ragazzi viene suggerito che fare domande dimostra ignoranza? E quanto incidono le reazioni infastidite dei genitori, i quali agli interrogativi dei figli rispondono: “Non chiedere tanto”, oppure: ”Stai attento, invece di chiedere”? Non sono forse simili commenti e reazioni a provocare, nei bambini, e poi nei ragazzi, una certa insicurezza che porta alla perdita della capacità di fare domande?
E se imparassimo a chiedere?
Dopo aver disimparato a domandare, è difficile, da adulti, riprendere a fare domande. Non ne siamo più capaci, ci sentiamo in imbarazzo. E allora ci capita di svicolare facendo domande che non sono reali domande, o perché conosciamo già la risposta, o perché le formuliamo in modo tale da ottenere la risposta desiderata. Addirittura, molte volte rinunciamo del tutto a domandare per pigrizia, rassegnazione o timidezza: quante domande importanti, che riguardano noi stessi, le nostre relazioni e i fatti e le dinamiche del mondo restano inespresse? Quante volte – in ufficio, a scuola, in officina, in casa – non osiamo porre domande che pure ci permetterebbero di aprire finestre attraverso cui far entrare aria fresca? E a volte non poniamo domande per paura di dover accettare di cambiare idea, se la nuova informazione ottenuta contraddice la nostra precedente convinzione.
Lo scopo delle domande è quello di arrivare a nuove intuizioni, di capire meglio i problemi, di aprire nuove prospettive. Non dovremmo dimenticare che ogni domanda che rinunciamo a fare è un’occasione perduta non solo in termini di comprensione, di conoscenza e di relazione, ma anche in termini di creatività. I bambini di quattro anni questo lo sanno benissimo.
Una preghiera per concludere
I commentari rabbinici dicono che gli angeli scolpiti sulla cassa di legno contenente le tavole della legge, avevano la faccia di bambini. Perché avevano la faccia di bambini? Perché i bambini pongono domande: vogliono sapere, vogliono capire, sono curiosi. Quando non facciamo più domande, significa che siamo vecchi, o che siamo morti.
Porre delle domande significa tenersi alla larga sia dal dogmatismo che dallo scetticismo. Il dogmatismo crede di possedere tutte le risposte, lo scetticismo crede che non ci siano risposte. Né il dogmatismo né lo scetticismo pongono delle domande. Il dogmatismo è una forma di orgoglio spirituale, lo scetticismo una forma di disperazione esistenziale. Sono due atteggiamenti ai quali contrapporre la paradossale versione del “Padre nostro” proposta da un pensatore francese. “Dacci oggi la nostra fame quotidiana”: fame di risposte, fame di conoscenza, fame alimentata dalla curiosità e dalla voglia di porre domande.
















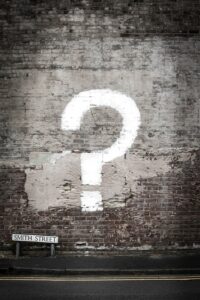

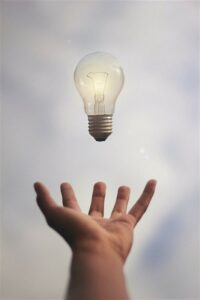



Considerazioni molto interessanti, grazie!
Per quanto riguarda le domande che ampiano le conoscenze “scolastiche”, a Brusio gli insegnanti ci ripetevano in continuazione di non esitare a porre domande e personalmente ho fatto tesoro di questo insegnamento e ne ho tratto grandi benefici e ne ho vantaggi anche ora.
Nell’ambito delle relazioni con gli altri una domanda che mi piace tanto è “Come stai?” seguita da un silenzio che permette di formulare la risposta. Chiedendo ad una persona come sta, le si lascia veramente l’opportunità di esprimersi. Ad una domanda del tipo “Tutto a posto?!” con l’intonazione più di affermazione che di interrogazione si può dare solo una domanda superficiale, perché tutto a posto non è praticamente mai. Forse a volte non si chiede per non dover affrontare la risposta?